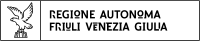LE TIGRI
DEL FRIULI
LE TIGRI
DEL FRIULI
Qui abbiamo raccolto alcuni risultati di una ricerca semi-seria e non lineare che ripercorre la vicenda delle Tigri di Monteaperta: la prima squadra di tiro alla fune femminile d’Italia, nata nel 1962 da un gruppo di donne sul confine italo-sloveno.
Nelle prossime cinque sezioni troverai i principali temi attraverso cui abbiamo analizzato questa storia. In ognuna di queste ti invitiamo a fare “due passi” in compagnia di uno studioso d’eccezione.
Ci auguriamo che, come è stato per noi, una piccola storia di ieri possa aprirti nuovi interrogativi sull’oggi.
Tutto iniziò nell’estate del 1962, durante una festa di paese. Proprio in quei giorni c’era un torneo di tiro alla fune e ad alcune donne del posto venne l’idea di sfidare la squadra maschile dei “Leoni di Collalto”. Consapevoli che non avrebbero potuto vincere sul piano della forza fisica, le donne decisero di giocare d’astuzia e, approfittando della confusione della festa, legarono una parte della corda ad una camionetta parcheggiata lì vicino. La sfida contro i “Leoni di Collalto” finì in parità, la folla entusiasta applaudiva le ragazze che presero nuovo coraggio e fiducia in sé stesse dando inizio all’avventura delle “Tigri di Monteaperta”, nome che riecheggiò dall’Alta Val Torre a tutta l’Italia.
Era una festa nella festa, c’era il tiro alla fune ma c’era anche da bere, da mangiare, la musica, la fisarmonica […] Seguirle era diventata proprio una tradizione. Era pieno di gente che le tifava, avevano quasi più tifo loro che le squadre maschili. All’inizio era stato difficile ma poi sono riuscite a crearsi un pubblico di affezionati sia in Friuli che fuori. Era quasi una cosa coreografica. Alla fine, non penso che a loro interessasse vincere o perdere, il senso era dato da questa festa che si era creata attorno a loro.
ALBERTA, Figlia di una Tigre di Monteaperta
Io ho conosciuto le Tigri inizialmente per la loro fama. Ho deciso di andare a presentarmi facendo una proposta per aumentare la loro popolarità e loro hanno accettato. Così ho cominciato a fare le cose in regola, abbiamo trovato una divisa, si allenavano due giorni per settimana. […] Quando ci hanno chiamati per fare Portobello è stato molto emozionante perché andare alla Rai era una cosa grande. Abbiamo organizzato una corriera, c’erano anche tanti ospiti oltre la squadra, la corriera era piena zeppa. Durante la trasmissione mi sono messo in una cabina telefonica: mentre loro erano sul palco io ricevevo le telefonate da tutte le organizzazioni sportive d’Italia. Portobello ci ha dato una popolarità che io non mi aspettavo, sono rimasto molto contento. Abbiamo viaggiato dalla Sicilia in su fino in Svizzera, a Lugano. È stata una soddisfazione molto grande perché ho visto queste donne assieme, impegnate; era un po’ faticoso tenerle a bada, ma insomma abbiamo fatto delle belle figure. Diverse ditte ci hanno offerto vestiario, ci hanno offerto altre opportunità. Eravamo noti, io sono diventato presidente, mi avevano eletto durante una serata in una trattoria. Ho trovato l’allenatore che era anche un massaggiatore. Agli allenamenti al posto di liquidi per massaggiatori avevamo le bottiglie di Merlot. Era semplice, era bello, si attirava tanta gente. Era una novità vedere delle donne fare quello sforzo pesante. Avevamo una lunga corda, tante volte si legava la corda ad un palo nel retro e non riusciva a batterci nessuno. Era bello. Ed è passato tanto tempo.
BRUNO, Manager della squadra delle Tigri di Monteaperta
Un giorno l’Ileana si trovava su a Montemaggiore dove c’era una sua amica, anche lei aveva un ristorante, quel giorno c’era la festa del paese. Solitamente durante la festa c’era una competizione di tiro alla fune tra maschi ma quel giorno c’era solo un gruppo, i Leoni di Collalto. Così all’Ileana è venuta l’idea di fare una squadra tutta femminile per cercare di combattere i Leoni e così hanno fatto. Hanno tirato su 4, 5, 6 persone, donne belle corpose, e si sono messi a fare questa gara. All’insaputa dei maschi la squadra delle donne aveva legato la cima della loro corda ad una camionetta della finanza. I maschi tiravano mentre loro facevano finta. La sfida è finita a pari merito senza che nessuno si accorgesse dell’inganno. Da questa giornata sono partite e hanno cominciato a fare varie gare perché venivano chiamate in giro per tutte le sagre dei paesi vicini. Tra loro le Tigri sono rimaste amiche, han fatto un gruppo bello corposo, si divertivano ad andare in giro più che fare le competizioni. Quelle che facevano erano goliardate, non erano proprio gare vere e proprie, lo scopo era principalmente divertirsi e far divertire, proprio per questo venivano chiamate dappertutto. Quel periodo non era semplice per le donne, tanti dicevano che le donne non erano capaci a fare quello che facevano gli uomini, le Tigri invece hanno dimostrato che lo potevano fare. A mano a mano che andavano avanti diventavano sempre più “serie”, riuscivano a battere le squadre maschili. La cosa particolare è che sono state le prime a fare una cosa del genere.
GIANNI, Organizzatore della mostra su Ileana Carloni e le Tigri di Monteaperta
Questa vicenda delle Tigri mi fa pensare che a volte si può essere innovativi senza neanche sapere di esserlo. (…) Nonostante fossero momenti in contrapposizione rispetto a quella che era l’immagine tradizionale o che veniva attribuita alla donna, “devi fare così, devi fare colà ” o “non è bene far così”, sono convinta che per loro questi fossero dei momenti di libertà. Anche se in maniera giocosa, facendosi forza a vicenda hanno portato alla ribalta un paese. Non hanno avuto paura di rappresentarsi in maniera diversa, uscendo da dei cliché. Poi magari a casa tornavano ad essere com’erano prima però quella delle Tigri era un po’ la bolla nella quale potevano essere diverse e se stesse. Loro si divertivano nel farlo, nessuno le aveva obbligate, si sono dette “loro credono che non siamo capaci di fare una cosa del genere, ma sì che ci riusciamo, dai, proviamo!”. È il discorso della competizione alla fine, far vedere che non valevano meno degli altri. E proprio perché valevano sono riuscite a dare visibilità ad un paese di cui nessuno aveva mai sentito parlare.
MARIA CRISTINA, Sociologa
In quella fune c’era la rabbia di anni di rotture di scatole, anni di sveglia all’alba, anni di figli attaccati alla gonna. C’era la rabbia del mondo, per quello vincevano secondo me. In quelle sfide di tiro alla fune c’era la voglia di giocare, ma anche la voglia di dimostrare qualcosa: “Cavolo, ho tirato su 4 figli da sola, mi sveglio ogni mattina alle 5 e vado a fare fieno, cosa vuoi che sia una corda, dammi qua, la tiro da sola”.
MARIA GRAZIA, Nipote di una Tigre di Monteaperta
Io sono stata coinvolta da una mia carissima amica che conosceva Ileana. Credo di essere stata scelta perché sono un po’ pazzerella e allora ha pensato che avessi il carattere giusto per portarmi dentro. Siccome poi lei veniva con me, si rideva, si scherzava e si andava a cercare le novità, ho accettato di entrare. (…) Mio marito non è mai venuto in giro con le Tigri ma io andavo lo stesso, gli dicevo “se vuoi venire bene, se non vuoi venire io vado lo stesso”. Non poteva esserci solo il lavoro e la famiglia bisognava anche uscire. (…) Tra di noi non si parlava mai dei problemi, si pensava solamente a divertirsi. Era fondamentale l’amicizia tra noi, quando ci trovavamo eravamo tutte una per l’altra. (…) Andare a Portobello è stato bellissimo. Siamo partite con il pullman da Udine, mi ricordo che Ileana Carloni doveva avere sempre una bottiglia di rosso e di bianco e diceva “eh prendo una pastiglia” e giù a bere. (…) Quando sono entrata nello studio della RAI sono rimasta molto meravigliata, non ero mai stata in uno studio né della rai né di niente. Poi quando è arrivato anche Tortora ho sentito una grande allegria dentro me stessa. Abbiamo sfidato una squadra di uomini dalla Sicilia con cui poi la sera siamo andati a cena insieme. Era tutto un bere, mangiare, tutto un caos, ci siamo divertite.
MILVA, Tigre di Monteaperta
Ileana era una mezza pazza, a stare con lei si passava di quelle giornate favolose. Lei era simpaticissima, aveva sempre la battuta pronta. Il suo sorriso e il suo modo di fare ci teneva sempre tutte allegre. Quando ho incontrato Ileana a Monteaperta la prima volta l’impatto è stato subito di una persona di famiglia.
MILVA, Tigre di Monteaperta
Eravamo tutte uguali, non poteva entrare nel nostro gruppo una che non era pressappoco pazzerella come noi. Non sarebbe resistita. Noi ci divertivamo, tra scherzi, cantare, gioire, si rideva per stupidaggini. In quegli anni ci si divertiva con poco. Quando siamo andate a Gemona la prima volta a tirare la fune in mezzo ai filari delle viti ci hanno portate su un carro con una gabbia. Noi eravamo tutte dentro e al microfono annunciavano “stanno arrivando le Tigri”. La gente stava sui filari dell’uva a guardarci, ci buttavano la paglia dentro nella gabbia. Facevamo questo tipo di stupidaggini però ci divertivamo.
MILVA, Tigre di Monteaperta
Io ho visto le Tigri gareggiare da bambino, mi affascinavano e impressionavano allo stesso tempo. Le guardavo veramente dal basso in alto, alcune di loro avevano un’imponenza e una forza che lasciavano senza parole. Vederle giocare contro squadre maschili e vincere era stupefacente. Non arrivavano mai ultime. Tra i bambini era un momento sentito, importante. Stavamo in silenzio, impressionati dalla loro forza, quello di cui sono sicuro è che non ci lasciavamo andare in commenti denigratori, non era proprio possibile. Sicuramente non erano il tipo di donne che eravamo abitati a vedere a casa. Durante le competizioni, da parte delle squadre maschili, c’era la stessa concentrazione nello sfidare una squadra di donne o di uomini, non c’erano differenze, bisognava giocarsela bene tutta. SIMONE, Spettatore delle esibizioni delle Tigri di Monteaperta
È una storia importante soprattutto per il mito che queste donne sono riuscite a creare dal niente, da un paesino di montagna e in un momento così difficile. Sicuramente è un esempio di forza e di importanza e spirito di gruppo. Si trattava di donne che lavoravano nel campo, in montagna, raccoglievano il fieno, trasportandolo magari con la gerla e trovavano il tempo per andare a fare l’allenamento, per stare insieme, divertirsi e portare la storia di questi posti un po’ in giro, farlo conoscere.
NATASCIA, Organizzatrice della mostra su Ileana Carloni e le Tigri di Monteaperta
Le tigri del Friuli, 1998
Dalla premessa di Domenico Zannier
“Bruno Fabretti riporta con velata nostalgia la leggenda delle “Tigri di Monteaperta”, che in seguito furono appellate le “Tigri del Friuli”, dopo gli eventi drammatici del sisma del 1976. In quel periodo di lutti e di macerie un drappello di donne meravigliose recarono una nota di spirito e di allegria nella nostra Regione. Il tiro alla fune di una squadra tutta femminile divenne popolare come le sue protagoniste. L’avventura di Portobello, la famosa trasmissione RAI-TV di Enzo Tortora, dischiuse loro le platee dell’Italia intera. Poi dopo i trionfi (ma c’è chi ne continua l’eredità sportiva) l’inesorabile corsa del tempo, gli anni che si accumulano, i gusti e le mode che cambiano.”
Mia mamma era nata e cresciuta a Udine quindi in una cultura completamente diversa da quella di Monteaperta. Anche se Udine è piccola è pur sempre una città, quando invece inizi a spostarti in su, là neanche non ti salutano; perché sono un po’ ostici, sono un po’ chiusi, specialmente da queste parti. Forse è stato anche questo a favorirla, un’apertura mentale rispetto a quei paesi. È da dire che nonostante questo mia madre non si è mai messa su un piano di confronto: io sono cittadina e tu sei paesotta. Non era da lei. Quando ha deciso di entrare nelle Tigri qualche sua amica di Udine ha commentato “sei matta” ma lei è sempre andata avanti, non ha mai fatto paragoni, esclusioni, niente, proprio lei era fatta così.
ALBERTA, Figlia di una Tigre di Monteaperta
C’è una generazione di mezzo che è una generazione priva di strumenti, impreparata, fragile come non lo era mai stata prima. Sono donne che avevano avuto prima delle madri o delle nonne con la possibilità di andare in giro per il mondo, che avevano una consapevolezza di che cos’è la vita libera, di che cosa vuol dire guadagnarsi la vita, essere stimate. Le donne che invece affrontano questo particolare momento storico, quello della guerra fredda sono una generazione scandalosamente fragile che ha seguito i mariti nelle miniere, che è stata bombardata dal terrore della guerra fredda. Si crea una frattura, le donne di quel periodo sono tutte donne fragili, incapaci di essere belle prima dentro che fuori.
Il femminismo arriva insieme alla televisione, va detto anche questo, sono molti i fenomeni che si incrociano. La televisione qui arriva negli anni ’50, pian piano le donne iniziano a guardarsi, si riflettono in altre immagini, e questo magari crea ancora più a disagio. Questo è un periodo in cui in questi territori non accade nulla, è tutto fermo, tutto pietrificato dalla paralisi, dalla paura di che cosa accadrà. Ma non solo, la paralisi è dovuta anche dal senso di colpa di avere una lingua e una cultura che è quella del nemico. La gente da queste parti parla sloveno, lingua che rimane attivissima fino al tempo del terremoto. Tutti parlavano lo sloveno, una lingua proibita. I figli non devono imparare a parlare quella lingua, perché quella lingua è la lingua del nemico. Nessuno l’ha mai detto in modo esplicito però è chiaro che chi parla queste lingue slave è comunista. Chi vive in questi territori si trova sul margine di due civiltà, di due culture e lingue e mondi diversi. Cresci facendo parte di un mondo che all’improvviso diventa del nemico. Diventi automaticamente anche tu nemico, quindi inaffidabile, quindi non vali niente, in questo contesto tu come donna vali ancora meno. Questo crea una frattura enorme che porta alla “bruttezza”. Le Tigri possono essere interpretate come una via di fuga a quella paranoia del tempo che vivevamo, un tempo così assurdo, violento, soffocante, claustrofobico. Il tiro alla fune apre una via di fuga, un senso di leggerezza, una dimensione che osa. Un desiderio di libertà, una cosa che rompe questa cappa folle che avvolgeva tutto il territorio di confine. Quel graffio delle Tigri ti apre uno squarcio di libertà in tutti i sensi, uscire dalle regole e forse per questo un’idea di vita vissuta così come i maschi, bere, misurarsi con la forza.
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
Una donna dietro il bancone di un bar/osteria, che adesso è quasi normale, era considerata quasi come la tenutaria di un casino perché aveva a che fare costantemente con gli uomini. Nei bar andavano soprattutto gli uomini e non era proprio che parlassero di messa, erano argomenti da uomini e trattati senza nessun tipo di censura. Quella dietro il banco non era quasi considerata un orecchio femminile, era quella dietro al banco, faceva parte della combriccola. (…) Questo rapporto “privilegiato” con il maschile è determinante per le Tigri. Molte di loro lavoravano in osteria. Una donna dietro al banco era più forte di un uomo dietro il banco.
MARIA GRAZIA, Nipote di una Tigre di Monteaperta
Io non ho mai sentito direttamente lamentele ma ogni tanto qualche voce arrivava magari tramite l’amica che riferiva “guarda quello lì ha chiesto se non abbiamo cose da fare a casa” o “guarda lì quelle donne…”. In quel periodo le donne dovevano stare a casa, prendersi cura dei figli e del marito, andare a lavorare. Io lavoravo in quel periodo, ero infermiera, dovevo chiedere le ferie per andare a fare le trasferte con le Tigri.
MILVA, Tigre di Monteaperta
Mi ricordo che quando avevo dieci anni vedevo mia madre parlare e fare alcuni scioperi per i diritti delle donne. Io ho sempre pensato che avessero il diritto di uguaglianza perché ricordo che mia madre andava in fabbrica a lavorare 8 ore, magari dalle 2 alle 10, poi arrivava a casa e si metteva sul mastello a lavare i panni fino a mezzanotte/l’una per tenere la famiglia sempre pulita, per tenerci sempre in ordine. Mentre magari mio papà era a giocare a carte. In quegli anni facevano bene a fare queste lotte per ottenere gli stessi diritti e gli stessi doveri in tutto. Gli uomini una volta erano così, mi ricordo che in paese molti erano contadini, andavano a portare il latte e poi si fermavano nei bar e lì rimanevano a giocare a carte e la moglie che si arrangi. Molti invece emigravano lasciando la moglie a casa a gestire i figli, la stalla, la campagna, le galline, le oche. In quegli anni là aveva sicuramente più lavoro la donna ed era quindi giusto che le donne facessero quello che hanno fatto. Anche io essendo stata in famiglia con mia madre ho preteso che mio marito mi desse una mano. I primi anni è stato un po’ più difficile ma poi dopo piano piano si è amalgamato ed è venuto avanti. Gli dicevo sempre “bello, se io dovessi mancare o che dovessi ammalarmi devi almeno saperti cucinare un uovo” oppure “vieni qua, vedi come faccio io” lui magari mi diceva e “eh ma io vado…” “sì, vai a lavorare? Vado a lavorare anch’io”. Io ero infermiera e facevo i turni di notte, smontavo la mattina e dopo dovevo venire a casa e mettermi a fare tutte le cose.
MILVA, Tigre di Monteaperta
Come da tutte le parti, c’era il Friuli istituzionale, quello della democrazia cristiana che vinceva sempre tutte le elezioni a livello regionale e poi quello della bassa friulana, che era invece tradizionalmente di sinistra quindi le sagre erano le feste dell’unità, mentre nel resto del Friuli le sagre erano quelle della parrocchia. Possiamo trovare proprio questa distinzione riflessa tra le sagre. In quegli anni, a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, la società era ancora molto ingessata e tradizionalista; dal punto di vista culturale non c’era niente, c’era il cinema ferroviario, che adesso il Cec sta gestendo come visionario, forse c’erano le primissime stagioni di teatro contatto e poi c’era il teatro tradizionale. C’erano pochi, pochissimi, concerti. Non c’erano festival, non c’erano i concerti in castello o allo stadio, non c’era niente di tutto questo. In questa situazione c’era ben nascosto anche un altro Friuli, quello alternativo e underground, che in quegli anni segnava il passaggio tra la cultura post ’68 e ’77. (…) Nel vuoto totale di offerta culturale le sagre costituivano uno dei pochi luoghi di incontro, soprattutto con anche realtà che si conosceva poco. La gente non andava quindi molto al teatro e ai concerti ma tutti, anche gli alternativi, andavano in sagra a mangiare, bere e incontrare altra gente. Quindi posso immaginare l’effetto dirompente che hanno avuto le tigri nel loro tour nelle sagre, probabilmente era il modo per farsi conoscere maggiormente che si potesse sfruttare in quel momento.
PAOLO, Giornalista
Mi viene in mente anche un’altra modalità tipica friulana: quella di fare le cose ma promuoverle poco, tenerle un po’ nascoste. In questo invece le Tigri sono state rivoluzionarie andando, non so dire se grazie ad una strategia o per i casi della vita, subito al centro dell’attenzione che all’epoca era la televisione. Loro sono andate dritte lì, al centro della scena, facendosi conoscere da tutti con grande fastidio della gente della sinistra o della scena alternativa. L’apparizione delle Tigri a Portobello era vista come una roba trash, il tiro alla fune, questa femminilità sboccata e anche volgare, volutamente volgare.
PAOLO, Giornalista
Udine o Gorizia sono città molto piccole quindi spesso i ragazzi, venendo dai paesi, finché non cominciavano a frequentare le scuole superiori, che in genere erano a Udine, non andavano quasi mai in città. La vita nei paesi era molto più importante e organizzata di oggi e si esprimeva anche attraverso le sagre o fenomeni come quello delle Tigri. Il riferimento non era la città ma erano la gente, le associazioni, i bar, le realtà dei paesi. Questo è un aspetto importante del Friuli che si sta perdendo: la società, la vita, la vivacità dei paesi.
PAOLO, Giornalista
Di seguito alcuni titoli che mettono in risalto gli aspetti legati al confine, al rapporto con la Slovenia, agli aspetti culturali e antropologici. Nella seconda parte alcuni titoli per inquadrare i movimenti legati al 1968 in Friuli.
Tarcento e la Valle del Torre
in O. Marinelli, Guida delle Prealpi Giulie
di G. Bragato e O. Marinelli
Del Bianco, 1981
Dettagliata sezione dedicata all’alta Val Torre, dentro un’importante tappa di ricerca, svolta all’inizio del Novecento (Società Alpina Friulana, Udine 1912), nello studio geografico del territorio, in un intreccio di aspetti fisici e umani.
Terska dolina – Alta val Torre – Val de Tor
M. Kozuh (a cura di)
Goriska Mohorjeva, 2006
Raccolta di saggi in lingua slovena, italiana e friulana, di vari autori sulla geografia, la storia e l’arte dell’alta Val Torre, con 33 composizioni in quattro lingue dello scrittore di Lusevera Guglielmo Cerno.
Cultura materiale dell’alta Valle del Torre
in G. Ellero (a cura di), Tarcint e Valadis de Tôr
di R. Dapit
Società Filologica Friulana, 1996
La difficile sopravvivenza delle attività economiche legate all’ambiente naturale nell’area slovena dell’alta Valle del Torre.
Dispersi i legami col passato
in “Il punto friulano”, n. 12, 15 luglio 1979
di B. Sibille-Sizia
Una lucida e amara analisi sull’alta Val Torre post-terremoto: la difficile ricostruzione e la fuga.
Maschere e mascherate nell’alto Torre
in G. Ellero (a cura di), Tarcint e Valadis de Tôr
di A. Nicoloso Ciceri
Società Filologica Friulana, 1996.
Studio antropologico sulla maschera come elemento artigianale, artistico e spettacolare nella cultura popolare dell’alta val Torre.
Interazione linguistica nell’alta valle del Torre: isomorfia, eteromorfia e polimorfia
in G. Ellero (a cura di), Tarcint e Valadis de Tôr
di P. Merkù
Società Filologica Friulana, 1996.
Saggio sulla ricchezza data dalla polimorfia del repertorio toponomastico dell’alta Valle del Torre.
Una comunità per l’arte. Artisti tarcentini del ‘900
di Giuseppe Bergamini, Lucio Tollis
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, (Catalogo della mostra, dicembre 2008 – marzo 2009).
Tra gli artisti tarcentini, il rapporto uomo-territorio diventa conoscitivo nell’arte di Albino Lucatello, ispirata anche all’alta Val Torre e ai “Musi”.
Il territorio carsico di Taipana
Centro ricerche carsiche Carlo Seppenhofer,
supplemento di “Sopra e sotto il Carso”, Gorizia, 2012.
Progetto multidisciplinare di ricerca speleologica in un territorio dalla conformazione singolare che plasma realtà e atmosfera.
Lusevera e l’alta val Torre
Atti del Convegno, Cleup, (Pradielis, 13 dicembre 1986).
Raccolta degli interventi del convegno sul territorio che circonda Lusevera, di cui si affrontano vari aspetti legati alla peculiarità e pluralità del contesto.
L’alta val torre e le sette ville slave
in G. Ellero (a cura di), Tarcint e Valadis de Tôr
di O. Burelli
Società Filologica Friulana, 1996.
Il microcosmo dell’alta Valle del Torre con le sette sue “ville” slave: Lusevera, Musi, Pradielis, Cesariis, Micottis, Vedronza e Villanova.
La zona di confine
Di T. Maniacco
Bottega Errante Edizioni, 2017.
C’è anche l’alta Valle del Torre nella zona di confine narrata tra il dentro, il fuori e il dietro le cose, in una pluralità di lingue, linguaggi e forme d’arte.
La rivoluzione è una farfalla. Sessantotto friulano e dintorni
di Paolo Medeossi Gaspari Editore, 2018
Carnia, Cividale, Trieste, Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Grado, e poi Roma, Milano, Parigi, Praga, Londra, Berkeley, il mondo… Le distanze si annullarono e un’intera generazione, improvvisamente e dovunque, non volle più replicare ciò che erano i genitori, i professori, insomma quelli oltre i 30 anni, cambiando tutto e facendosi sentire per la prima volta.
Ma non vedete nel cielo… Storia del ’68 friulano
di Andrea Valcic Kappa Vu, 2008
Il Sessantotto friulano nella sua fase iniziale, ancora (forse) ingenuo ma certamente forte di quella spinta e di quella capacità di penetrazione che solo l’aggregazione spontanea attorno a temi comuni, al disagio di una generazione e alle sue speranze potevano dare. Un anno vissuto intensamente e riportato fedelmente da uno dei protagonisti.
Friuli Venezia Giulia, regione di confine
Di Gian Paolo Gri
Capitolo tratto da “Fortezza FVG, Dalla guerra fredda alle aree militari dismesse” di Moreno Baccichet
Edicom Edizioni, 2015
Gri spiega quanto sia difficile, da antropologo, pensare al Friuli come frontiera di “difesa” o comunque militarizzata. Nella disciplina che studia l’uomo e la sua cultura, il termine indica spesso arrivare alle teorie di sporco/pulito di Mary Douglas. In questa ottica, il Friuli non è una fortezza (di difesa militarizzata) bensì un territorio di scambio e contaminazione.
La grande trasformazione. società ed economia in Friuli negli anni del boom economico
Di Marco Puppini
Capitolo tratto da “Il Friuli: Storia e società. Dalla guerra di Liberazione alla ricostruzione. Un nuovo Friuli. Vol. V 1943-1964” di A. Buvoli
Ist. Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2012
In questo testo si comincia a comprendere come negli anni del terremoto si cominciasse a manifestare la crescita economica della regione. Il Friuli avrebbe, in quegli anni, avviato uno sviluppo soprattutto delle piccole e medie industrie: il terremoto del 1976 ed i successivi (e rapidi) fondi mossi dallo Stato non hanno di per sé avviato una ripresa economica ma sono stati utilizzati in modo oculato per far riprendere le aziende che negli anni prima avevano dimostrato validità e vivacità economica.
Paesaggi in Friuli. Dalla Guerra Fredda alla globalizzazione
di Alma Bianchetti
Capitolo tratto da “Il Friuli: Storia e società. Dalla guerra di Liberazione alla ricostruzione. Un nuovo Friuli. Vol. V 1943-1964” di A. Buvoli
Ist. Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2012
Alma Bianchetti nel suo ampio studio si sofferma sui mutamenti intervenuti nei paesaggi in Friuli in conseguenza dei processi che hanno portato a profonde e complesse trasformazioni socioeconomiche della regione.
Inizialmente c’è stato chi le ha criticate. Dalla parte maschile c’era chi non era favorevole proprio perché erano delle donne, siamo negli anni ’70, per molti la donna doveva stare a casa a fare la polenta. Quindi all’inizio i maschi erano un po’ riluttanti, poi dopo invece, con l’andare avanti degli anni sono diventati anche loro dei fan e venivano a vedere le gare. Mi ricordo appunto alle feste che si facevano qua in zona… i maschi si erano un po’ rilassati mentalmente in un certo senso.
ALBERTA, Figlia di una Tigre di Monteaperta
Quando nasce il movimento femminista in questo territorio è un fulmine a ciel sereno in una cultura ancora tranquilla e devota, anche se bisogna ricordare che qui le donne avevano una loro autonomia. Le donne andavano sempre a messa, tutto era molto ordinato. Ma in cuor loro e nella loro testa c’era un elemento, una forza, che era quella di guida della famiglia e anche una consapevolezza economica molto forte. Le donne che entrano in questa lega femminista erano donne che lavoravano, erano anche già entrate in fabbrica (…). Le ragazze che avevano frequentato l’università, avevano gli strumenti culturali per interpretare il femminismo come liberazione della donna, mentre quelle che abitavano nei paesi erano donne che in un certo senso erano tornate indietro, vivevano immerse in un sistema che le assegnava un ruolo marginale.
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
La migrazione lascia scoperte le famiglie dai maschi più produttivi, quindi il ruolo della donna nelle famiglie alpine diventa un ruolo centrale, un ruolo importante. Vale qui come anche a Monteaperta, per cui esiste che nelle famiglie c’è una sorta di matriarcato, che vuol dire la capacità di gestire l’economia della famiglia. È un’economia minima, piccola, fatta della gestione della stalla, dei campi e non solo, dato che gestivano pure l’economia dei guadagni che i mariti mandavano dal loro andare da ambulanti in giro (…)
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
Quando ricomincia la vita, le donne tornano ad andare alle superiori, a studiare e poi via via così, torna e rifiorisce questa bellezza. Secondo me questa è un po’ la storia di questa parte orientale, di queste montagne che hanno vissuto tutte le contraddizioni del secolo scorso. Da qui un femminismo come dimensione di consapevolezza e di lotta, anche aggressiva, capace di aggredire le ingiustizie, di rivendicare la giustizia. Il femminismo arriva con un’ampia diffidenza: quelle donne erano viste come comuniste. Qui era molto facile, quando uno era un po’ diverso, essere etichettato come comunista, un po’ lo schema “non sei come me quindi sei comunista”.
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
Certi uomini seguivano le Tigri, le varie mogli o fidanzate, certe invece andavano da sole alle competizioni: partivano e tornavano anche tre giorni dopo. I mariti andavano fuori di testa perché rimanevano a casa e nessuno gli preparava da mangiare. Ad esempio, Mafalda prendeva e partiva e tornava magari dopo 2 o 3 giorni e il marito doveva seguire le capre, le mucche, gli animali che avevano, l’orto… Tutti compiti che quella volta facevano le donne: loro seguivano tutto il ménage famigliare. Anche questo ha premesso di fare dei passi avanti, le Tigri hanno dimostrato che le donne non erano fatte solo per stare a casa ma potevano fare tante cose.
Quello era un periodo in cui le donne erano segregate in casa, non potevano fare nient’altro. Iliana è stata la prima a fare molte cose: si metteva le minigonne, gli short… cose che a quell’epoca erano inimmaginabili. Usciva da tutti gli schemi. Voleva fare quello che a lei interessava fare, non guardava in faccia a nessuno, prendeva e faceva, andava contro tutto quello che era lo standard di quel periodo. Le Tigri sono state le prime a uscire da certe dinamiche, forse è per questo che sono state incoraggiate, aiutate. Erano delle persone che meritavano, avevano una famiglia e dovevano seguire la casa; eppure, riuscivano a fare questo e quello, si divertivano perché il loro era puro divertimento. A loro non interessava stare negli standard di quell’epoca, loro si divertivano, non guardavano in faccia a nessuno. Prendevano e partivano com’erano vestite, magari ancora con su gli scarponi che avevano usato prima per pulire la stalla, andavano, non si preoccupavano. Di certo non si pitturavano per farsi vedere belle… loro erano genuine, si mostravano così com’erano. È forse questa la bellezza delle persone che erano, erano sincere.
GIANNI, Organizzatore della mostra su Ileana Carloni e le Tigri di Monteaperta
L’immagine fisica delle Tigri era molto mascolina… nella cultura dominante la donna doveva avere determinati connotati, atteggiamenti, magari un po’ sottomessi. Queste donne invece erano importanti, forti e decise. Erano donne che effettivamente potevano creare un po’ di scompiglio nell’immaginario classico della donna, specialmente quella friulana, che è una donna comunque sottomessa, una donna che lavorava, tante volte anche di più dell’uomo, ma che non aveva nessun riconoscimento. La caratteristica che mi colpiva, e allo stesso tempo mi faceva sorridere, era proprio questa forza. Ad attirare l’attenzione era questa loro mascolinità, le loro braccia, le loro gambe. […] Nonostante l’apparenza le facesse vedere come donne grezze, quasi contadine, non rientravano nei canoni della donna di città “che poteva essere di Udine piuttosto che di Cividale” erano donne che definirei quasi “terrigne”, che appartenevano alla terra. Ma al di là di questo aspetto esteriore e forse anche del modo in cui si presentavano io credo che nei loro confronti ci fosse anche una certa ammirazione per il loro coraggio. La donna friulana non è una donna che tende a mettersi in mostra in quegli anni. Loro invece hanno avuto il coraggio di rappresentarsi in una maniera che andava fuori gli schemi prettamente femminili, io credo abbia suscitato anche un certo orgoglio per quello che erano in grado di esprimere.
Io credo che la consapevolezza nasca dopo lunghe riflessioni. Il primo atteggiamento è un po’ individuale ed emotivo ed è forse dettato da tanti aspetti che sottostanno al fatto di volere riscoprirsi come donne in maniera diversa da come gli stereotipi ti davano. Tu prendi coscienza nella misura in cui hai delle opportunità anche culturali per poterlo fare, perché cominci a contrapporti, cominci ad analizzare le cose, dici “ma perché mia mamma faceva così, mia nonna faceva colà”, e “perché io devo fare così”. Non è solo un problema di ribellione, che è tipico di una certa età e che è anche giusto che ci sia nell’adolescenza. A mano a mano che vai avanti ti rendi conto che il tuo ruolo può essere diverso e questo lo puoi fare meglio sei hai un buon livello di istruzione oppure se trovi sulla tua strada delle persone che ti aiutano a crescere. Come fa una donna a prendere coscienza di certe cose io non lo so, dico semplicemente che ci sono tanti momenti in cui una persona si trova a dover fare delle scelte piccole e grandi, scelte che fai cercando anche di volerti bene, cercando le cose alle quali vuoi aspirare o con le quali puoi risponderti “mi farebbe bene così, mi piacerebbe fare colà”.
MARIA CRISTINA, Sociologa
Io credo che in quegli anni, soprattutto negli anni ’50 – ’60, quando io ero piccola, si confrontavano due generazioni, quella di mia madre e quella di mia nonna, che vivevano due mondi completamente diversi. Sembrano quasi due epoche distinte. Era come se mia madre volesse portare un mondo “nuovo” ma allo stesso tempo più convenzionale. Mia nonna invece, veniva da tutto quello che c’era stato prima: la guerra, la miseria, la storia personale, quattro figli, un marito assente. Un insieme di cose aveva fatto diventare quella donna un uomo, non lo dico come accezione positiva, gli eventi le avevano negato molte parti della sua femminilità per caricarsi di una responsabilità, di una forza, anche di un’incoscienza che non erano sue. Avevo anche un’altra nonna, quella materna, alla quale ero legatissima, anche lei una donna forte che però aveva avuto un percorso di vita completamente diverso. Nonostante la sua vena di follia non era mai diventata così “libera” dalle convenzioni. (…) Io considero mia nonna molto più emancipata di quello che è mia madre, nonostante mia mia madre abbia cominciato a lavorare a 14 anni, si è sempre mantenuta, ha sempre insegnato a noi figlie il valore dell’indipendenza però non si era mai trovata nella stessa condizione di mia nonna: l’essere sola, perché i mariti erano in guerra o per tutta una serie di eventi come avevi sposato quello che non aveva voglia di lavorare o perché succedeva che era all’estero, era morto, era alcolizzato… Questi fatti rendevano le donne molto più emancipate di quello che era il canone del periodo. Erano donne che si tiravano su le maniche e affrontavano la vita punto e basta, senza farsi troppi problemi “ho la gonna troppo corta o troppo lunga, ho i peli o non li ho”. La parte del femminile più convenzionale non esisteva più. Io trovo che fossero più emancipate di molte donne di oggi.
MARIA GRAZIA, Nipote di una Tigre di Monteaperta
Quando siamo andate in trasferta in Sicilia, a Marsala, potete immaginare i commenti che abbiamo sentito andando in giro. Là le donne erano tutte donne molto legate alla casa e ai mariti noi, invece, eravamo libere. Mi ricordo che noi andavamo a prendere il sole in bikini e sentivamo queste donne insultarci con parole troppo grosse che non posso ripetere ma potete immaginare. Loro erano sempre appiccicate ai mariti, perché a vederci noi così libere si erano sempre appiccicate ai mariti no. Noi di reazione non rispondevamo niente a parole ma si faceva peggio. Loro dicevano e noi si faceva ancora peggio, ad esempio c’erano 2 – 3 mie amiche che si toglievano anche il reggiseno, in quegli anni là potete solo immaginarvi la reazione ad un gesto del genere.
MILVA, Tigre di Monteaperta
Le generazioni che ho seguito come neuropsichiatra le ho viste un po’ legate dentro ad un nodo, avere da un lato un’educazione, una spinta a realizzarsi e dall’altro un bisogno evolutivo di essere protetti, di prendersi cura di altri. Queste due cose non andavano di pari passo. In Veneto si diceva sulla donna: “che la piasa, che la tasa, che la staga a casa”. La donna che non rientrava in questi canoni faceva fatica trovarsi in equilibrio e a sentire di piacere all’altro. Io credo che la questione femminile, in questo momento, sia da affrontare con i maschi; le donne sono arrivate ad una consapevolezza di sé che le ha messe però in un fortissimo contrasto su chi vogliono essere nel mondo, nella vita. Ora è arrivato il momento per gli uomini di scoprire la loro parte più femminile, devono far pace con un modo di essere umani che è essere forse non più maschio e femmina ma persona completa.
SILVANA, Neuropsichiatra
La prima parte di titoli è riferita al Friuli Venezia Giulia, con autrici friulane. Nella seconda parte si trovano titoli a carattere nazionale che sono stati scritti da autrici non friulane. Nell’ultima parte una raccolta di testi dedicati al tema donne e sport.
Niente come prima. Il passaggio del ’68 tra storia e memoria
M. Giovannelli (a cura di) Kappa Vu, 2007
Ricordi, ricostruzioni, riflessioni di 19 donne impegnate culturalmente in Friuli-Venezia Giulia che raccontano il ’68, anno dalla durata anomala per i suoi effetti e risvolti fino al nuovo millennio.
La donna nella cultura e nella realtà friulana dal ’45 ad oggi
Atti del 1° Convegno, Comune di Martignacco, 15-23 marzo 1980
Testimonianze e riflessioni sulla donna friulana nella società e nella cultura artistica e letteraria.
Scrittrici contemporanee in Friuli
Di M. Tore Barbina, A. Nicoloso Ciceri Rebellato Editore, 1984
Antologia di scrittura femminile in italiano e friulano, in versi e prosa, dal dopoguerra agli anni Ottanta.
Gli anni difficili Di M. Giovannelli Kappa Vu, 2011
Romanzo della rivoluzione. Il terremoto culturale prima del terremoto sismico: così appare la nuova soggettività femminile nel tradizionalista Friuli degli anni Settanta, attraverso la storia di cinque donne.
ncerte sono le parole Di E. Buiese Rebellato, 1974
Necessità e impossibilità di esprimersi in una raccolta di liriche della poeta friulana sull’amore e sullo stare al mondo delle donne.
Singolare femminile
Di G. Jacolutti
La Nuova Base, 1983
Sette ritratti in versi di donne di tutte le età attraversate dallo sguardo della scrittrice e poeta udinese.
Poesiis
Di Emily Dickinson, traduzione di Maria Tore Barbina La Nuova Base, 1986.
Importante diffusione dell’opera della Dickinson in Friuli, grazie alla traduzione di Maria Tore Barbina, impegnata nella difesa della lingua del territorio e dell’universo femminile.
Madri e figlie degli anni ’80, la realtà della donna in Friuli
Di Anna Maria Boileau e Andrea Moretti
Grillo, Udine
Due volumi organizzati in differenti interviste condotte per volere dell’assessore dei pari diritti (anno 2006). Le interviste vengono riportate in prima persona dalle varie testimonianze raccolte sul criterio comune di coinvolgere donne che abbiano vissuto (nell’arco di periodo 1914-2006) in una stretto contatto con il confine italiano orientale. Da qui la maggior parte delle intervistate sono state condotte con donne triestine di un ceto ed un contesto che reputo lontano da quello che ci può interessare. Mi sono focalizzato quindi sulla testimonianza di persone vissute in zone più o meno montuose del FVG.
Le filosofie femministe
Di F. Restaino, A. Cavarero Paravia Scriptorium, 1999
La pluralità del pensiero femminista emerge dai vari criteri di analisi, storico, filosofico, tematico, geografico, in un confronto di contesti, italiano e internazionale.
Lo strabismo della memoria
Di L. Melandri
La Tartaruga, 1991
Una raccolta di scritti-ricerca dell’autrice faro del femminismo, che disegnano una rilettura della dimensione personale e sociale della donna.
Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie
Di F. Lussana Carocci, 2012
Un’inedita storia del movimento femminista italiano, dal post-miracolo agli anni Novanta, per tentare di delineare un quadro complessivo nazionale e colmare il silenzio e l’anonimato che spesso hanno contrassegnato i gruppi femministi.
Cambiare il mondo. Viaggio nel pensiero femminile
Di C. Benussi
Edizioni Unicopli, 2014
Una filosofia della vita opposta alla prassi vincente emerge da una complessa e condensata analisi del pensiero femminile che intreccia dimensioni sociale, antropologica, sacra, emotiva, artistica, letteraria, teorica, storica, dall’antichità ai nostri giorni, di respiro locale, nazionale e mondiale.
Donne di frontiera: Vita, società. cultura e lotta politica nel territorio di confine orientale italiano nei racconti delle protagoniste
A cura di Gabriella Musetti, Silvana Lampariello Rosei, Marina Rossi, Dunja Nanut.Il Ramo d’Oro, 2006, Trieste.
Testimonianze biografiche di donne appartenenti a diverse culture e classi sociali: imprenditrici, scienziate, artiste, insegnanti, casalinghe, ecc.; ciascuna delle quali ha operato all’interno del proprio contesto socioculturale e professionale affrontando con coraggio situazioni di criticità e drammaticità. Narrano la storia ricca e tumultuosa di una zona di confine, attraverso il racconto delle loro battaglie private e pubbliche, dei conflitti personali, delle contraddittorietà tra sentimento e ragione, nell’affannosa ricerca della propria identità storico sociale, ma anche della propria identità femminile.
Donne e sport. Riflessioni in un’ottica di genere
G. Virgilio e S. Lolli (a cura di)
I Libri di Emil, 2018
Inedite analisi e riflessioni di genere: il risvolto sociale, i pregiudizi, le discriminazioni, la formazione atletica, l’immagine mediatica e le capacità delle donne nei vari ruoli del mondo sportivo. Uno studio nato dall’incontro tra l’associazione femminista bolognese “Orlando” e l’esperienza di Sara Simeoni, primatista mondiale nel 1978.
Identità femminile e sport
Di A. Salvini
La Nuova Italia, 1982
Risvolti psicologici dell’attività sportiva della donna, vista come momento individuale e dimensione sociale in cui si forma e si esprime l’identità femminile.
Sessismo e sport. Una critica femminista in A. Roversi, G. Triani (a cura di), Sociologia dello sport
Di N. Shinabargar
Esi, Roma, 1995
Una riflessione sui movimenti femministi e sulla donna dentro il mondo sportivo.
In quegli anni su questo territorio c’è la guerra fredda, di là c’è il mondo comunista, di qua c’è il mondo della “libertà”. Questi due mondi si fronteggiano. In questo fronteggiarsi si crea quel cuscinetto per cui chi si trova nel mezzo è investito da una forma di controllo del territorio affinché i comunisti non entrino. Si crea quindi una situazione paranoica per chi sta fermo lì; le grandi strategie hanno tutte un senso ma per chi si trova lì, nel cuscinetto, c’è la paranoia. E in questo contesto, quindi, le rivoluzioni legate al ’68 o al ‘77 ti appaiono come una cultura di sinistra e dunque sospetta esattamente come quella dei tuoi nemici al di là del confine.
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
Qui appena uno era un po’ diverso era comunista, secondo lo schema per cui “se non sei come me sei comunista”, non importa che cosa sei, sei comunista perché quello diventa il termine che sporca maggiormente. Per tantissimo tempo qui ha funzionato così, quella parola serviva a dire “di te non mi fido, sei il peggio che c’è, sei comunista”.
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
Mafalda quand’era giovane aveva una malga a pochi chilometri dal confine. Quella volta il confine era chiuso, pattugliavano sia dalla parte italiana che dalla parte slovena. In quel periodo le pattuglie erano composte sia di finanzieri che soldati, erano squadre che si davano il cambio. Uguale dalla parte slovena. Mafalda cantava, era allegra, naturalmente attirava l’attenzione. Questa fanciulla era un po’ ambita da una parte e dall’altra del confine. Nonostante fossero di turno in pattuglia, un giorno i soldati della parte slovena hanno scavalcato il confine che si trovava a metà del fiume ed è successo un po’ un patatrac tra sloveni e italiani. Non so che cosa si possano essersi detti in quell’occasione. Lei è scappata però continuava tranquilla la sua vita beata, stava tutta l’estate là e non gli mancava di certo la compagnia perché anche i giovanotti di qua andavano via a trovarla.
ANITA, Mascotte delle Tigri di Monteaperta
I primi titoli si rifanno a pubblicazioni più recenti di narrativa che vanno a raccontare l’immaginario del confine orientale, la storia attraverso la letteratura. Successivamente si possono trovare una serie di titoli che vanno a raccontare il confine orientale fino ai giorni nostri. Si sono volutamente tralasciati tutti i titoli sul confine orientale durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale.
La veglia di Ljuba
di Angelo Floramo
Bottega Errante Edizioni, 2018
La vita intensa di un uomo, esule più per vocazione che per destino, fuori dagli schemi, diventa lo spunto per narrare la storia del Novecento lungo il confine tra Italia e Jugoslavia. Dai villaggi dell’Istria profonda alle pagine nere del fascismo, dall’occupazione titina di Trieste al terremoto in Friuli del 1976 e alla successiva ricostruzione, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Breve storia del Friuli. Le radici e l’identità di una regione di confine, sospesa tra tradizione rurale e innovazione cittadina
di Angelo Floramo Newton Compton, 2020
Nell’immaginario collettivo degli italiani il Friuli è una regione strana, dove si parla una lingua incomprensibile. Questa terra apparentemente marginale è stata per secoli il cuore di un’Europa plurale, di popoli, lingue e culture che qui si sono incontrati. Una storia sociale, in cui cultura, economia e paesaggio diventano chiavi importanti per comprendere meglio un territorio fiero e ricco di fascino. Un viaggio in una terra di frontiera, un nodo di confini, storie, sapori e paesaggi.
Il fiume a bordo
di Mauro Daltin, Alessandro Venier, Angelo Floramo Bottega Errante Edizioni, 2020
Dalla sorgente del fiume Tagliamento, attraversando tutta la Carnia per arrivare al borgo abbandonato di Portis e poi puntare a sud, toccando il ponte di Braulins, Spilimbergo, San Daniele, Latisana fino ad arrivare alla foce, a Lignano. E poi si riparte dalla Slovenia, dalla sorgente della Soca, si giunge a Gorizia, passando per Caporetto e Tolmino. E da lì si segue l’acqua dell’Isonzo fino all’Isola della Cona sulle tracce della Grande Guerra.
La malaluna
Di Maurizio Mattiuzza Solferino, 2020
Una famiglia friulana di lingua slovena stretta nelle maglie del confine orientale. Un padre soldato e una donna minuta, forte come mille uomini, che la Prima guerra mondiale strappa, assieme ai tre figli, dalla propria terra nel nome di un destino collettivo e familiare segnato dalla rotta di Caporetto e dall’ascesa di quel fascismo di confine che evoca misteri e vendette mai sopite.
L’Italia e il confine orientale.
Di Marina Cattaruzza
Il Mulino, Bologna 2007
Nella storia d’Italia il confine orientale ha sempre costituito una zona di scontro: prima luogo simbolico in cui doveva compiersi l’azione risorgimentale tesa al raggiungimento dell’unificazione nazionale, poi confine di mondi e ideologie negli anni della guerra fredda.
Storia del confine orientale italiano 1797-2007. Cartografia, documenti, immagini, demografia
Di F. Cecotti, B. Pizzamei Irsml FVG, Trieste 2007
Una serie utile di documenti, immagini di repertorio, articoli sul confine orientale fino ai giorni nostri.
Il tempo dei confini.
Storico dell’Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e mediterraneo 1748-2008
di F. Cecotti
Irsml FVG, Trieste 2010
L’Atlante propone la visione dei cambiamenti di confine dall’epoca della Repubblica di Venezia fino ai tempi recenti nell’area dell’Alto Adriatico e dell’Adriatico Orientale, ma inserito nella dinamica complessiva dei confini dell’Europa centrale e orientale e del Mediterraneo.
Storia degli sloveni in Italia 1866-1998
di Milica Kacin Wohinz, Joze Pirjevec Marsilio, 1998
La storia degli sloveni in Italia è quella di un rapporto ormai più che secolare tra maggioranza e minoranza, caratterizzato da una conflittualità non ancora risolta.
Il confine orientale e i conflitti dell’alto Adriatico.
Bibliografia ragionata
Di M.Orlić, M.Bresciani, Unicopli, 2011
Il volume fornisce un’agile e competente guida bibliografica rispetto ai temi riguardanti i complessi rapporti storici, politici e diplomatici relativi alle terre di confine tra Italia ed ex Jugoslavia, a partire dal periodo dell’Impero asburgico per arrivare al dopoguerra, passando per la dominazione fascista e la Seconda guerra mondiale.
Il terremoto ha fatto una cosa incredibile qua in Friuli, in tutto questo territorio, ha smosso tutto e ha fatto emergere l’esigenza di riconoscersi come friulani. Da qui la battaglia, piano piano condivisa da tutti, del friulano come lingua e la cultura friulana come cultura propria e non come cultura marginale.
DONATELLA, Architetta e ricercatrice
Io ho dato tutto quello che potevo per poter portare queste donne in tutta Italia, non per il fatto sportivo ma perché avevo nel cuore il terremoto e quindi le portavo per ringraziare tutte queste città per gli aiuti ricevuti. Purtroppo, anche i nostri paesi di Nimis, Monteaperta, Taipana sono stati duramente colpiti dal terremoto. Ci sono stati tanti i danni, anche la mia casa è crollata, è sprofondato il tetto dentro. Abbiamo ricevuto tanti aiuti.
Avevo fatto fare dei piatti grossi con scritto “Il Friuli vi ringrazia” che consegnavo nei nostri viaggi. Ho avuto delle presentazioni con vescovi, con personaggi importanti e regalavo a tutti questo piatto per ringraziare di quello che loro avevano fatto per noi durante il terremoto. Sono contento di averlo fatto perché queste donne se lo meritavano, il Friuli meritava di ringraziare tutta la gente d’Italia che ci ha aiutato a ricostruire le nostre case. Anche le autorità del Friuli-Venezia Giulia, che più volte abbiamo incontrato, ci dicevano di tenere duro, di andare avanti e di ringraziare i popoli che ci avevano aiutato. L’ho fatto con piacere e sono orgoglioso di averlo fatto.
BRUNO, Manager della squadra delle Tigri di Monteaperta
Quella volta del terremoto ero in casa mia proprio, è venuto la sera, è andato tutto per aria, ho avuto tanta paura. Avevamo le mucche, avevamo la stalla, vicino alla stalla c’era il fienile… tutte le mucche urlavano, era tutto un disastro. Dopo sono arrivati i finanzieri a cercare le famiglie per vedere se era morto qualcuno, invece noi eravamo tutti vivi, non ci era successo niente, solo qualche ferita. I finanzieri ci hanno portati tutti fuori e ci han riuniti sulla piazza. La chiesa era aperta a metà, è venuta giù in due parti.
MAFALDA, Tigre di Monteaperta
Del terremoto io ho dei ricordi molto nitidi perché mio padre è nato a Comerzo e gran parte della famiglia era a Maiano. Io avevo 12 anni. È stato tutto un scappa e corri, mia sorella ha pianto fino alle 6 di mattina del giorno dopo. C’era una gran tensione. I miei avevano il bar attaccato al comune e il sindaco aveva chiesto di tenerlo aperto. Mia madre che non voleva rimanere al chiuso aveva preso una ciotola di legno piena di gettoni, perché c’erano i gettoni per telefonare e noi avevamo il telefono pubblico, e la mette sul banco. Poi aveva messo sempre sul banco tutte le bottiglie di liquori e una riga di bicchieri. Noi poi siamo stati fuori. Quando a mezzanotte abbiamo chiuso c’erano tutti i soldi, tutti avevano preso quello che dovevano prendere e avevano lasciato i soldi. Questa è una cosa pazzesca. È stato questo poi quello che ci ha reso possibile uscire da quel periodo. Il terremoto è stato come un idrante che ha pulito un po’ tutti lasciando l’umanità vera, quella contadina, quella onesta, che si era persa un po’ in quegli anni. Con tutti i miei amici maschi ci eravamo coordinati con il partito comunista per andare ad aiutare le persone che avevano la casa lesionata a tirare fuori la roba, a falciare il campo dove dopo avrebbero piantato i prefabbricati che servivano. Avevo 12 anni. Noi in famiglia abbiamo avuto otto morti, non è stato un periodo semplicissimo e mi ricordo che alla radio davano i nomi delle persone che trovavano scavando il condominio di Maiano. Dopo i primi tempi in cui dormivamo in macchina avevamo organizzato una specie di campeggio nella piazza di Feletto, tutti con le tende, c’era chi faceva la torta, chi portava il vino, era sagra ogni sera. C’era necessità di questo, si aveva bisogno di stare insieme, di ridere, di giocare, di scherzare, avevi bisogno perché se no impazzivi. Tutti avevano avuto qualche problema, dalla famiglia di origine o qualche amico.
La comunità era la forza che ti sosteneva.
MARIA GRAZIA, Nipote di una Tigre di Monteaperta
In questa raccolta abbiamo evitato tutti i titoli di giornalisti e narratori italiani che hanno raccontato il terremoto essendo stati inviati sul posto, concentrandoci sui titoli più “friulani” e significativi.
Le pietre dello scandalo. La politica dei beni culturali nel Friuli del terremoto.
Scritti di Binaghi Olivari, Cacitti, Dalai Emiliani, Della Bianca, Doglioni, Ericani, Marchetti, Roccella, Rossignani, Sicoli.
Einaudi, 1980.
Libro collettivo per favorire un’azione comune a salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.
Un cane da catena
di Bruna Sibille-Sizia
Doretti editore, 1987.
Per l’analisi storico letteraria dell’opera si rimanda a Un cane da catena: il terremoto del Friuli per la prima volta in un romanzo, in Una voce carpita e sommersa di Martina Delpiccolo, Kappa Vu 2019.
Friuli: la prova del terremoto
a cura di Raimondo Strassoldo e Bernardo Cattarinussi. Prefazione di Achille Ardigò.
Franco Angeli editore 1978.
Il volume raccoglie una serie di ricerche condotte dall’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia sulle reazioni psico-sociali e politico-organizzative dopo il terremoto in Friuli.
Pa sopravivence, no pa l’anarchie
di Igor Londero.
Forum editrice, 2008.
L’estate del 1976 nelle tendopoli di Gemona rivissuta attraverso la memoria collettiva.
La ricostruzione possibile
di Giovanni Pietro Nimis.
Marsilio editori, 1988.
Storia della ricostruzione nel centro storico di Gemona.
Modello Friuli. La risposta al terremoto del 1976
di Luciano Di Sopra.
Biblioteca dell’immagine, 2016.
Il libro racconta come nacque la protezione civile in Italia.
Friuli. Un popolo tra le macerie.
Di David Maria Turoldo, Francesco Placereani, Duilio Corgnali, Gian Carlo Menis e altri autori.
La Vita Cattolica, 2016.
Ristampa di un libro apparso nel 1976.
Quando la terra tremò.
Messaggero Veneto 2016.
Con un racconto inedito di Pierluigi Cappello e le memorie dei cronisti del giornale friulano.
La notte che il Friuli andò giù. Dieci voci raccontano il terremoto del ’76.
Bottega Errante edizioni 2016.
Un canto collettivo, corale, per ricordare la notte del 6 maggio 1976.
Venzone e il duomo. Scrigno superbo di cultura medievale e di rinascita
di Luciano Simonitto.
Aviani & Aviani, 2016.
Storia di come venne ricostruita una cittadella murata con il suo simbolo.
Ricostruire la memoria. Il patrimonio culturale del Friuli a quarant’anni dal terremoto.
A cura di Corrado Azzollini e Giovanni Carbonara.
Forum editrice, 2016.
Il volume raccoglie gli atti del convegno organizzato a Udine nel maggio 2016 dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dall’Azienda speciale Villa Manin di Passariano sul restauro e sul ripristino del patrimonio culturale friulano danneggiato dal terremoto.
Il terremoto in Friuli
di Paolo Cossi.
Becco Giallo, 2016.
Paolo Cossi, friulano, disegna una graphic novel che non si limita solo a raccontare il terremoto, ma ce lo fa vivere con le piccole storie quotidiane di quelli che sono i protagonisti di questa storia: gente comune, con i loro guai, i loro piccoli tradimenti, sotterfugi, le viltà di cui solo gli esseri umani sono capaci.
Friuli 1976. Il terremoto che cambiò la storia.
Di Renato Zanolli.
De Bastiani, 2016.
Una raccolta dei racconti dei cronisti che hanno seguito il terremoto per i giornali dell’epoca.